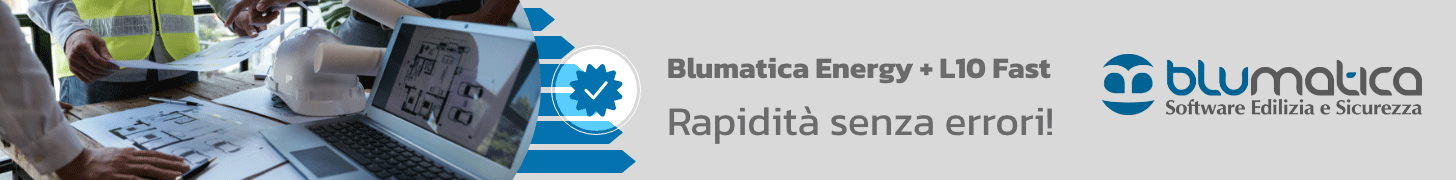Speciale 47
Innovazioni del Freddo e del Condizionamento, il XV Convegno Europeo
Referenza
Alternative naturali e sintetiche a basso GWP
Allo stato attuale delle cose sembra che i refrigeranti candidati alla maggior diffusione nel futuro saranno gli HFO, talvolta miscelati con altri fluidi che possono presentare anche un GWP maggiore (R32, R134a) e i fluidi naturali, che da sempre sono presenti sul mercato e vengono utilizzati perché garantiscono un basso GWP ed una buona efficienza.
Semplificando un po’ il discorso e con una certa dose di humour possiamo notare che le soluzioni alle problematiche poste dall’uso dei refrigeranti si possono raggruppare in due filoni: quello chimico e quello meccanico.
L’approccio chimico ha come elemento ispiratore la necessità di comportare minimi cambiamenti agli impianti esistenti, ai componenti, ai controlli, ai sistemi produttivi, perpetuando il tentativo di sintetizzare molecole che possano mantenere alte le rese degli apparecchi. Ovviamente questa risulta essere la soluzione a minor costo dal punto di vista dei manager che devono trovare soluzioni al problema.
L’approccio meccanico, al contrario, dovrebbe tentare di costruire il circuito frigorifero attorno al refrigerante, possibilmente naturale: progettare un circuito (ma anche apportargli delle modifiche) richiede però un impegno economico significativo, poiché i fluidi che di solito vengono presi in considerazione possiedono proprietà termodinamiche e termofisiche diverse di quelle dei refrigeranti utilizzati attualmente. In altre parole le loro soluzioni sono maggiormente costose.
Così, le risultanze più comuni sono che l’approccio chimico risulta meno costoso nel breve periodo ma non ha un futuro certo, mentre l’approccio meccanico risulta migliore nel lungo periodo, ma è più complesso e costoso.
Dopo un periodo in cui si sono messi al bando vari tipi di refrigeranti è difficile trovare buone molecole per ogni applicazione (basse e bassissime temperature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, pompe di calore ad alta temperatura, piccoli e grandi sistemi, etc,).
I refrigeranti di nuova generazione appena introdotti sul mercato (gli HFO) hanno un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), ma comportano dei problemi di infiammabilità e tossicità. Anche le miscele azeotropiche (che solitamente rappresentano delle soluzioni semplici per i progettisti di scambiatori di calore e permettono un contenimento della carica) offrono una scelta limitata. Riuscire ad individuare una buona miscela ha l’obiettivo di raggiungere una soluzione che un singolo componente non può fare da solo.
Attualmente si sceglie di miscelare i refrigeranti HFO, che hanno pressioni caratteristiche basse e presentano un basso GWP, con refrigeranti ad alta pressione per creare fluidi sostitutivi idonei per una particolare applicazione. Fluidi di pressione più elevate sono in genere candidati interessanti perché offrono migliori possibilità di avere impianti compatti: tubazioni più piccole (a causa della minore sensibilità alle perdite di carico), scambiatori più piccoli, ecc.
Nei sistemi a compressione di vapore queste opzioni sono rappresentate da:
Nei sistemi ad assorbimento
(in genere applicazioni di nicchia in cui il calore risulta essere disponibile in abbondante quantità e a costi ridotti):
Negli impianti a turbina :
L'anidride carbonica rappresenta una valida soluzione alternativa anche per le applicazioni automobilistiche, ma sembra che l'industria abbia scelto l’R1234yf come opzione sostitutiva più facile ed apparentemente a più basso costo.
Problemi tipici degli impianti con refrigeranti naturali sono la compatibilità dei materiali e la riduzione di carica per l'ammoniaca (a causa della sua media tossicità e infiammabilità) e per gli idrocarburi, a causa della loro infiammabilità. Nel caso del’anidride carbonica l'attenzione è focalizzata sulla sua efficienza a causa delle sue diverse proprietà termodinamiche e termofisiche rispetto a molti altri refrigeranti che possono farla sembrare un’opzione a bassa efficienza.

Semplificando un po’ il discorso e con una certa dose di humour possiamo notare che le soluzioni alle problematiche poste dall’uso dei refrigeranti si possono raggruppare in due filoni: quello chimico e quello meccanico.
L’approccio chimico ha come elemento ispiratore la necessità di comportare minimi cambiamenti agli impianti esistenti, ai componenti, ai controlli, ai sistemi produttivi, perpetuando il tentativo di sintetizzare molecole che possano mantenere alte le rese degli apparecchi. Ovviamente questa risulta essere la soluzione a minor costo dal punto di vista dei manager che devono trovare soluzioni al problema.
L’approccio meccanico, al contrario, dovrebbe tentare di costruire il circuito frigorifero attorno al refrigerante, possibilmente naturale: progettare un circuito (ma anche apportargli delle modifiche) richiede però un impegno economico significativo, poiché i fluidi che di solito vengono presi in considerazione possiedono proprietà termodinamiche e termofisiche diverse di quelle dei refrigeranti utilizzati attualmente. In altre parole le loro soluzioni sono maggiormente costose.
Così, le risultanze più comuni sono che l’approccio chimico risulta meno costoso nel breve periodo ma non ha un futuro certo, mentre l’approccio meccanico risulta migliore nel lungo periodo, ma è più complesso e costoso.
Maggiore difficoltà a trovare nuove molecole
Dopo un periodo in cui si sono messi al bando vari tipi di refrigeranti è difficile trovare buone molecole per ogni applicazione (basse e bassissime temperature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, pompe di calore ad alta temperatura, piccoli e grandi sistemi, etc,).
I refrigeranti di nuova generazione appena introdotti sul mercato (gli HFO) hanno un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), ma comportano dei problemi di infiammabilità e tossicità. Anche le miscele azeotropiche (che solitamente rappresentano delle soluzioni semplici per i progettisti di scambiatori di calore e permettono un contenimento della carica) offrono una scelta limitata. Riuscire ad individuare una buona miscela ha l’obiettivo di raggiungere una soluzione che un singolo componente non può fare da solo.
Attualmente si sceglie di miscelare i refrigeranti HFO, che hanno pressioni caratteristiche basse e presentano un basso GWP, con refrigeranti ad alta pressione per creare fluidi sostitutivi idonei per una particolare applicazione. Fluidi di pressione più elevate sono in genere candidati interessanti perché offrono migliori possibilità di avere impianti compatti: tubazioni più piccole (a causa della minore sensibilità alle perdite di carico), scambiatori più piccoli, ecc.
Refrigeranti naturali alternativi
Nei sistemi a compressione di vapore queste opzioni sono rappresentate da:
- Ammoniaca (R717);
- Idrocarburi (R600a, R290), e altre soluzioni per basse temperature, come propano, propilene, etano, ...;
- Anidride carbonica (R744);
- Aria (R729) per gli impianti a bassa temperatura degli aerei;
- Acqua (R718) (basse pressioni e grandi impianti in termini di capacità);
- Elio negli impianti con ciclo Stirling per applicazioni di nicchia.
Nei sistemi ad assorbimento
(in genere applicazioni di nicchia in cui il calore risulta essere disponibile in abbondante quantità e a costi ridotti):
- Ammoniaca/acqua, ecc;
Negli impianti a turbina :
- Vapore (quando il vapore è disponibile quasi gratis).
L'anidride carbonica rappresenta una valida soluzione alternativa anche per le applicazioni automobilistiche, ma sembra che l'industria abbia scelto l’R1234yf come opzione sostitutiva più facile ed apparentemente a più basso costo.
Problemi tipici degli impianti con refrigeranti naturali sono la compatibilità dei materiali e la riduzione di carica per l'ammoniaca (a causa della sua media tossicità e infiammabilità) e per gli idrocarburi, a causa della loro infiammabilità. Nel caso del’anidride carbonica l'attenzione è focalizzata sulla sua efficienza a causa delle sue diverse proprietà termodinamiche e termofisiche rispetto a molti altri refrigeranti che possono farla sembrare un’opzione a bassa efficienza.