Speciale 76
Applicazioni e caratteristiche dei nuovi gas refrigeranti naturali e sintetici
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Cudicio Maurizio – Libero Professionista www.proenco.it
I nuovi gas refrigeranti naturali e sintetici: impieghi e caratteristiche
I gas refrigeranti trovano largo uso e diffusione sia negli impianti di climatizzazione, sia tra le apparecchiature utilizzate nel settore della refrigerazione, e questo, nel corso degli anni, ha permesso un notevole e indubbio miglioramento della qualità di vita di ogni singola persona. Ne è un esempio l’ampia diffusione dei climatizzatori di cui ormai quasi la totalità delle costruzioni è dotata, già a partire dalle nostre case.
I refrigeranti affondano le proprie origini nel 1834, periodo nel quale i fluidi utilizzati erano di tipo naturale, ossia acqua, ammoniaca, anidride solforosa, anidride carbonica ed etere, per poi vedere l’introduzione del protossido di azoto nel 1912. Si deve attendere il 1920 per vedere i primi impianti frigoriferi alimentati con etano o propano.
Purtroppo alcuni di questi fluidi sono stati abbandonati nel corso degli anni a causa della loro pericolosità, a parte alcuni che ancora oggi vengono utilizzati come ad esempio l’ammoniaca. Essi lasciarono il posto nel 1930 a sostanze diverse, più stabili e sicure, sia in fase di lavorazione che in fase di utilizzo, inodori, non infiammabili e soprattutto meno costosi. Tra i fluidi frigoriferi di nuova generazione si ricordano il CFC-11 (R11), CFC-12 (R12) e, in seguito, HCFC-22 (R22) e R502 (miscela di HCFC-22 e CFC-115).
Purtroppo però molte delle sostanze utilizzate si sono rivelate nel corso degli anni nocive per l’ambiente, soprattutto per l’atmosfera. Nel 1994, infatti, a seguito del protocollo di Montreal, è stato stabilito l’inutilizzabilità di tali sostanze. Negli anni successivi è stata concessa la sola rigenerabilità degli stessi fino al 2014, permettendo e garantendo un passaggio quanto più indolore per tutti gli impianti che negli anni precedenti sono stati realizzati.
Tabella 1 - Elenco dei fluidi refrigeranti inquinanti
Numerosi studi sono stati eseguiti al fine di determinare ed individuare fluidi che potessero rispondere alle esigenze di sostenibilità ambientale, basso costo, sicurezza e che ovviamente potessero prendere il posto dei refrigeranti banditi. Tra i fluidi che ad oggi risultano essere utilizzabili troviamo R23-R134A-R404A-R407C-R410A-R507-R508A. Molte di queste sostanze hanno un impatto elevato sul riscaldamento globale ma non hanno potere ozono-lesivo e pertanto ne è concesso l’uso.
Essi rientrano nella famiglia degli HFC ossia gli idrofluorocarburi che sono totalmente privi di cloro e con i quali è stato possibile raggiungere l’obiettivo di ODP (Ozone Depletion Potential: potere di danneggiamento dell’ozono) nullo. In questi fluidi, infatti, l’idrogeno ha preso il posto del cloro, abbattendo pertanto la nocività dei refrigeranti. Questo comporta però un problema: se la quantità di idrogeno che compone la sostanza è rilevante, il fluido diventa infiammabile, infatti alcuni HFC (R32, R143A e R152A) risultano essere infiammabili.
I fluidi frigoriferi pertanto, negli ultimi anni, hanno visto una notevole diffusione soprattutto nel settore della climatizzazione estiva ed invernale, data l’enorme diffusione di sistemi di condizionamento con inversione di ciclo a pompa di calore, soprattutto a seguito della pubblicazione di alcune normative e leggi nazionali, tra cui si può citare il D.Lgs 28/2011, che prevede e impone lo sfruttamento di energie rinnovabili, con le quali è possibile ridurre gli inquinanti immessi e tra le quali rientrano anche le pompe di calore.
Un ciclo frigorifero è un ciclo termodinamico nel quale avviene un trasferimento di calore da un ambiente a bassa temperatura ad uno ad alta temperatura, permettendo di utilizzare le macchine come macchina frigorifera. Una macchina frigorifera pertanto è un’apparecchiatura che è in grado di raffreddare un ambiente abbassandone la temperatura, cedendo il calore sottratto all’esterno, e in modo opposto, ossia invertendo il ciclo di funzionamento, la stessa unità può essere utilizzata in pompa di calore, garantendo e permettendo il riscaldamento dei locali.
Esistono fondamentalmente tre tipologie di ciclo termodinamico che permettano di svolgere questo ciclo, e più precisamente:
• Ciclo a compressione o di Kelvin;
• Ciclo ad Assobimento;
• Ciclo di Stirlin.
In tutti e tre i casi ovviamente è necessario svolgere un lavoro, che comporta una naturale generazione di energia che deve essere dispersa sotto forma di calore. Sta poi alla modalità di funzionamento della macchina (ciclo estivo o ciclo invernale), identificare dove e verso quale ambiente, tale energia debba essere dissipata.
Il ciclo a compressione, è uno dei cicli maggiormente diffusi nella produzione di macchine frigorifere e si basa sullo sfruttamento di un ciclo di compressione per permettere al fluido frigorifero di subire una trasformazione da gassoso a liquido. La compressione del fluido comporta un cambiamento di stato dal quale si determina la produzione di calore che pertanto viene estratto dal ciclo, per poi essere espanso.
Da tale espansione di determina l’evaporazione del liquido che ovviamente determina una sottrazione di calore.
Pertanto il ciclo si suddivide in quattro fasi principali:
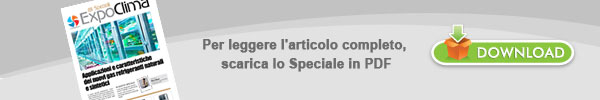
Photo Credit: Caleffi
I refrigeranti affondano le proprie origini nel 1834, periodo nel quale i fluidi utilizzati erano di tipo naturale, ossia acqua, ammoniaca, anidride solforosa, anidride carbonica ed etere, per poi vedere l’introduzione del protossido di azoto nel 1912. Si deve attendere il 1920 per vedere i primi impianti frigoriferi alimentati con etano o propano.
Purtroppo alcuni di questi fluidi sono stati abbandonati nel corso degli anni a causa della loro pericolosità, a parte alcuni che ancora oggi vengono utilizzati come ad esempio l’ammoniaca. Essi lasciarono il posto nel 1930 a sostanze diverse, più stabili e sicure, sia in fase di lavorazione che in fase di utilizzo, inodori, non infiammabili e soprattutto meno costosi. Tra i fluidi frigoriferi di nuova generazione si ricordano il CFC-11 (R11), CFC-12 (R12) e, in seguito, HCFC-22 (R22) e R502 (miscela di HCFC-22 e CFC-115).
Purtroppo però molte delle sostanze utilizzate si sono rivelate nel corso degli anni nocive per l’ambiente, soprattutto per l’atmosfera. Nel 1994, infatti, a seguito del protocollo di Montreal, è stato stabilito l’inutilizzabilità di tali sostanze. Negli anni successivi è stata concessa la sola rigenerabilità degli stessi fino al 2014, permettendo e garantendo un passaggio quanto più indolore per tutti gli impianti che negli anni precedenti sono stati realizzati.
|
Gas clorofluorocarburi CFC
|
Gas idroclorofluorocarburi HCFC
|
|
R 12
R 13
R 500
R 502
R 503
|
R 22
R 408A
R 409A
|
Numerosi studi sono stati eseguiti al fine di determinare ed individuare fluidi che potessero rispondere alle esigenze di sostenibilità ambientale, basso costo, sicurezza e che ovviamente potessero prendere il posto dei refrigeranti banditi. Tra i fluidi che ad oggi risultano essere utilizzabili troviamo R23-R134A-R404A-R407C-R410A-R507-R508A. Molte di queste sostanze hanno un impatto elevato sul riscaldamento globale ma non hanno potere ozono-lesivo e pertanto ne è concesso l’uso.
Essi rientrano nella famiglia degli HFC ossia gli idrofluorocarburi che sono totalmente privi di cloro e con i quali è stato possibile raggiungere l’obiettivo di ODP (Ozone Depletion Potential: potere di danneggiamento dell’ozono) nullo. In questi fluidi, infatti, l’idrogeno ha preso il posto del cloro, abbattendo pertanto la nocività dei refrigeranti. Questo comporta però un problema: se la quantità di idrogeno che compone la sostanza è rilevante, il fluido diventa infiammabile, infatti alcuni HFC (R32, R143A e R152A) risultano essere infiammabili.
I fluidi frigoriferi pertanto, negli ultimi anni, hanno visto una notevole diffusione soprattutto nel settore della climatizzazione estiva ed invernale, data l’enorme diffusione di sistemi di condizionamento con inversione di ciclo a pompa di calore, soprattutto a seguito della pubblicazione di alcune normative e leggi nazionali, tra cui si può citare il D.Lgs 28/2011, che prevede e impone lo sfruttamento di energie rinnovabili, con le quali è possibile ridurre gli inquinanti immessi e tra le quali rientrano anche le pompe di calore.
Il circuito frigorifero
Un ciclo frigorifero è un ciclo termodinamico nel quale avviene un trasferimento di calore da un ambiente a bassa temperatura ad uno ad alta temperatura, permettendo di utilizzare le macchine come macchina frigorifera. Una macchina frigorifera pertanto è un’apparecchiatura che è in grado di raffreddare un ambiente abbassandone la temperatura, cedendo il calore sottratto all’esterno, e in modo opposto, ossia invertendo il ciclo di funzionamento, la stessa unità può essere utilizzata in pompa di calore, garantendo e permettendo il riscaldamento dei locali.
Esistono fondamentalmente tre tipologie di ciclo termodinamico che permettano di svolgere questo ciclo, e più precisamente:
• Ciclo a compressione o di Kelvin;
• Ciclo ad Assobimento;
• Ciclo di Stirlin.
In tutti e tre i casi ovviamente è necessario svolgere un lavoro, che comporta una naturale generazione di energia che deve essere dispersa sotto forma di calore. Sta poi alla modalità di funzionamento della macchina (ciclo estivo o ciclo invernale), identificare dove e verso quale ambiente, tale energia debba essere dissipata.
Ciclo a compressione o di Kelvin
Il ciclo a compressione, è uno dei cicli maggiormente diffusi nella produzione di macchine frigorifere e si basa sullo sfruttamento di un ciclo di compressione per permettere al fluido frigorifero di subire una trasformazione da gassoso a liquido. La compressione del fluido comporta un cambiamento di stato dal quale si determina la produzione di calore che pertanto viene estratto dal ciclo, per poi essere espanso.
Da tale espansione di determina l’evaporazione del liquido che ovviamente determina una sottrazione di calore.
Pertanto il ciclo si suddivide in quattro fasi principali:
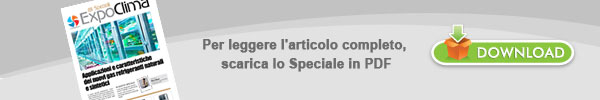
Photo Credit: Caleffi







