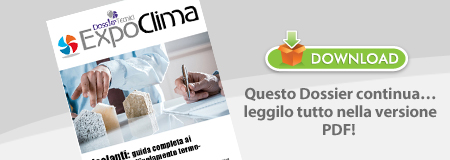Isolanti: guida completa ai prodotti per l’isolamento termo-acustico degli edifici
L'isolamento termico ed acustico dell’involucro edilizio si può ottenere mediante l'utilizzo di numerose tipologie di materiali, da quelle naturali a quelle sintetiche, per passare ai prodotti riciclati, le possibilità di scelta sono davvero molte, e si differenziano per specifiche caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche. I prodotti isolanti, continuamente studiati e migliorati, si evolvono in continuazione nel tentativo di garantire una sempre minore conducibilità termica e acustica, sia tentando di migliorare l'efficienza dei prodotti consolidati che sperimentando prodotti nuovi e composti innovativi. In questa sede analizzeremo, uno ad uno, i prodotti per la coibentazione, elencando le caratteristiche proprie di ciascun materiale, nel tentativo di fornire una guida completa sugli isolanti applicabili all'edilizia.

Le caratteristiche fondamentali degli isolanti per l'edilizia
La realizzazione di un "buon edificio" è costituita da varie fasi interdipendenti che partono dalla progettazione per giungere all'esecuzione. Il comfort abitativo è certamente legato alla buona progettazione degli spazi, ma senz'altro concerne imprescindibilmente anche sapienti scelte impiantistiche e metodi costruttivi volti al contenimento del fabbisogno energetico ed al mantenimento delle condizioni termoigrometriche desiderate all'interno degli ambienti. Che si tratti di ristrutturazione, riqualificazione o nuova costruzione, una parte considerevole del suddetto comfort dipende dalla qualità dell'involucro edilizio, nonché di quella degli impianti di cui verrà dotato l'edificio. È piuttosto ovvio che le ristrutturazioni risultino penalizzate in questo senso per limiti d'intervento, ad esempio la ristrutturazione di una singola unità immobiliare all'interno di un edificio costituito da più unità, mentre le nuove costruzioni diano la possibilità di realizzare, potenzialmente, un edificio efficiente e funzionale. In ogni caso gli interventi sull'involucro edilizio sono uno degli aspetti cruciali per la soddisfazione dell'utenza.
L'involucro di un edificio è l'insieme dato dalle superfici orizzontali e verticali (fondazioni/platea, coperture, elementi strutturali come pilastri, solette, cordoli, elementi di tamponamento murari, serramenti) che costituiscono l'architettura dell'edificio stesso; tale involucro è composto da superfici cosiddette opache (strutture, murature perimetrali, ecc.) e superfici cosiddette trasparenti (serramenti esterni, vetrate e tutti gli elementi dai quali è permesso il passaggio di aria e di luce naturali).
Affinché l'involucro edilizio risulti ben realizzato, si devono considerare, in fase di progettazione e di costruzione, gli accorgimenti necessari a limitare la dispersione di energia (ad esempio la naturale dispersione di calore di un locale riscaldato nel periodo invernale verso l'ambiente esterno la cui temperatura è inferiore) attraverso le superfici opache e trasparenti:
- uno strato coibente adeguatamente progettato posto sulle superfici opache fornisce un'eccellente protezione termica dell'involucro edilizio ed è essenziale per raggiungere alti livelli di efficienza energetica;
- superfici trasparenti a basso valore di trasmittanza termica Uw (ossia la somma della trasmittanza termica del vetro e di quella del telaio) che limitino al minimo le dispersioni di calore nel periodo invernale e che proteggano dall'irraggiamento nel periodo estivo.

La conducibilità termica λ (W/mK) esprime l'attitudine di un materiale a condurre il calore: la capacità isolante di un materiale è inversamente proporzionale al valore λ. Più quest'ultimo sarà alto minore sarà il potere isolante del materiale. Tuttavia, la scelta dell'isolante, oltre che dalla sua conducibilità, dipende dai requisiti funzionali che deve assolvere nella struttura. In certi contesti il requisito prevalente potrebbe essere la massa, per privilegiare l'elevato sfasamento termico, in altri la reazione al fuoco, oppure la resistenza a compressione o una maggiore diffusione al vapore. Infine, per sfruttare appieno il potenziale isolante dei materiali di coibentazione e dei differenti elementi costituenti l'involucro edilizio, occorre costruire in maniera tale da evitare i ponti termici, ossia quei punti nodali dell'edificio nei quali la dispersione energetica è favorita da:
- raccordo tra diversi materiali (murature, fondazioni, solai, tamponamenti, copertura, ecc.) i quali presentano differente continuità termica;
- punti di collegamento tra strutture murarie e differenti elementi (infissi e serramenti, cassoni di contenimento di tapparelle ed elementi oscuranti, soglie e davanzali, canne fumarie, ecc.);
- elementi architettonici a sbalzo, cavedi, camini e canne fumarie;
- elementi a diretto contatto con il suolo o con ambienti non climatizzati.
Quanto maggiore sarà l'ermeticità dell'involucro edilizio, ossia il suo strato isolante sarà continuo e i ponti termici saranno corretti o eliminati, tanto minori saranno le dispersioni termiche e, di conseguenza il fabbisogno energetico richiesto.

Per l'isolamento termico dell'involucro edilizio esistono svariate soluzioni e svariati materiali, lo sviluppo tecnico e tecnologico in questo settore è in continua evoluzione e in continuo aggiornamento al fine di garantire una bassa conducibilità termica attraverso soluzioni specifiche per ogni elemento da trattare (isolamento controterra, isolamento perimetrale verticale, correzione dei ponti termici, isolamento dei solai e delle coperture). In questa sede ci si concentrerà sulle tipologie di coibentazione di facciate e muri perimetrali, elencando le tipologie dei vari materiali isolanti e cercando di compararli in termini di origine, prestazioni e durabilità nel tempo.
In generale, non è soltanto la conduttività termica a guidare la scelta di un materiale isolante, esistono infatti altre caratteristiche che, a seconda dell'impiego, possono spostare la preferenza verso un materiale un altro:
- PRESTAZIONI MECCANICHE: la resistenza alla compressione è uno dei principali requisiti da valutare in quanto l'isolante, schiacciandosi per effetto dei carichi, offre una resistenza termica minore e può causare fessurazioni in altre parti della struttura (è il caso dei coibenti utilizzati sotto i massetti, controterra sotto platee e fondazioni, in copertura e nella zoccolatura dei sistemi a cappotto dove è richiesta una resistenza maggiore agli urti); in determinate applicazioni, come l'isolamento delle platee di fondazione o nelle coperture adibite a parcheggio per automezzi, è importante conoscere la resistenza a compressione a lungo termine con deformazione (schiacciamento) del 2% in 50 anni. Un altro parametro che caratterizza il comportamento a compressione di un isolante è la resistenza al carico concentrato (punzonamento) che può essere determinato, ad esempio, dal carico pedonale. Infine, va considerata, specialmente per le applicazioni a cappotto la resistenza a trazione;
- RESISTENZA AL FUOCO: indica il comportamento dell'isolante esposto direttamente a una fiamma di innesco. È una proprietà molto complessa in quanto dipende da vari parametri, di cui i principali sono:
- infiammabilità: capacità di un materiale di entrare e permanere in stato di combustione, con emissione di fiamme e/o durante l'esposizione a una sorgente di calore;
- velocità di propagazione delle fiamme: velocità con la quale il fronte di fiamma si propaga in un materiale;
- gocciolamento: capacità di un materiale di emettere gocce di materiale fuso dopo e/o durante l'esposizione a una sorgente di calore;
- post-incandescenza: presenza di zone incandescenti dopo lo spegnimento della fiamma (ad esempio brace) che potrebbero innescare nuovamente il fuoco;
- sviluppo di calore nell'unità di tempo: quantità di calore emessa nell'unità di tempo da un materiale in stato di combustione (potere calorifico);
- produzione di fumo: capacità di un materiale di emettere un insieme visibile di particelle solide e/o liquide in sospensione nell'aria risultanti da una combustione incompleta in condizioni definite;
- produzione di sostanze nocive: capacità di un materiale di emettere gas e/o vapori in condizioni definite di combustione.
La prestazione di reazione al fuoco viene definita dal sistema delle Euroclassi sulla combinazione di diversi test armonizzati; secondo le norme tecniche in quest'ambito gli isolanti sono raggruppati in 7 classi (da F ad A1):
 la classe al fuoco F è attribuita a prodotti per i quali non si determina la reazione al fuoco; possono appartenere a questa classe anche materiali che, pur essendo costituiti da prodotti che hanno un'ottima reazione al fuoco, sono accoppiati o rivestiti con materiali combustibili;
la classe al fuoco F è attribuita a prodotti per i quali non si determina la reazione al fuoco; possono appartenere a questa classe anche materiali che, pur essendo costituiti da prodotti che hanno un'ottima reazione al fuoco, sono accoppiati o rivestiti con materiali combustibili; le classi di reazione al fuoco dalla E alla B sono attribuite a prodotti di natura organica o inorganica ad elevato contenuto organico; la classe E si attribuisce eseguendo un test di piccola fiamma, mentre le classi dalla D alla B si attribuiscono sulla base del metodo di prova definito dalla norma armonizzata UNI EN 13823 (SBI), eseguendo un pre-test di piccola fiamma della durata di 30 secondi;
le classi di reazione al fuoco dalla E alla B sono attribuite a prodotti di natura organica o inorganica ad elevato contenuto organico; la classe E si attribuisce eseguendo un test di piccola fiamma, mentre le classi dalla D alla B si attribuiscono sulla base del metodo di prova definito dalla norma armonizzata UNI EN 13823 (SBI), eseguendo un pre-test di piccola fiamma della durata di 30 secondi; le classi di reazione al fuoco A1 e A sono attribuite a prodotti di natura inorganica. In questo caso il test SBI è integrato con la misura del potere calorimetrico (UNI EN 1716) e la prova di incombustibilità (UNI EN 1182);
le classi di reazione al fuoco A1 e A sono attribuite a prodotti di natura inorganica. In questo caso il test SBI è integrato con la misura del potere calorimetrico (UNI EN 1716) e la prova di incombustibilità (UNI EN 1182);
Oltre alla classe di reazione al fuoco, sono attribuiti ai materiali il livello di produzione di fumo (indicato con la lettera s – "smoke" - seguita da un valore numerico) e l'attitudine a rilasciare gocce incandescenti (indicata con la lettera d – "drops" - seguita da un valore numerico): tali suffissi sono in grado di rendere apprezzabile, ad esempio, la differenza tra due prodotti, entrambi in classe B, aventi il primo i suffissi s1, d0, utilizzabile nelle vie di esodo, e il secondo s1, d1, non utilizzabile nelle vie di esodo in quanto soggetto a gocciolamento;
- IGROSCOPICITÀ, TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ: sono tre caratteristiche legate al comportamento del materiale nei confronti dell'acqua, determinati dalla capacità di assorbimento della stessa per immersione o diffusione, dalla resistenza ai cicli di gelo/disgelo (igroscopicità e impermeabilità) e dalla permeabilità al vapore (traspirabilità). Per alcune applicazioni l'utilizzo di materiali igroscopici e impermeabili è necessario, come ad esempio nei già citati impieghi sotto fondazione o nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. In linea generale, è sempre preferibile l'utilizzo di materiali traspiranti (che possono essere anche impermeabili) ossia quelli con un basso coefficiente μ (fattore di resistenza al vapore), specialmente negli impieghi parietali in quanto la permeabilità della muratura è un requisito essenziale per la salubrità dell'ambiente interno poiché lo scambio tra interno ed esterno, combinato con la ventilazione naturale ed i sistemi di aerazione, consente di far uscire la maggior parte del vapore che si produce naturalmente negli ambienti indoor, evitando così la formazione di muffe, funghi e batteri;
- COMPORTAMENTO ACUSTICO: in alcuni impieghi, come ad esempio nell'isolamento di facciata o nell'isolamento tra unità attigue, è preferibile, se non necessario, associare alla caratteristica di isolamento termico anche quella dell'isolamento acustico. In linea di principio, l'isolamento acustico presenta differenti necessità da quelle termiche, motivo per cui gli isolanti acustici sono spesso pessimi isolanti termici e viceversa. La resistenza al flusso d'aria, caratteristica intrinseca del materiale, indipendente dalle dimensioni e dallo spessore, rappresenta la proprietà dei materiali di lasciarsi penetrare dall'aria e di impedirne il passaggio dal lato opposto, quindi consente di valutare possibilità di assorbimento e attenuazione acustica; pertanto, la migliore soluzione per combinare il taglio termico con quello acustico è quella di utilizzare materiali isolanti fibrosi o porosi, in quanto capaci di dissipare nelle loro cavità d'aria l'energia trasportata dal suono.
Altre caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta di un isolante, indipendenti dall'efficienza del materiale, sono senz'altro...