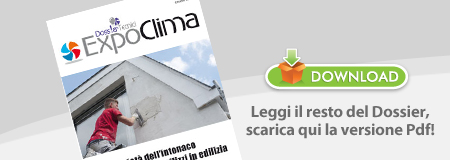Le proprietà dell'intonaco isolante e i suoi utilizzi in edilizia
L'imposizione di obblighi normativi finalizzati al risparmio energetico e la sempre maggiore attenzione del pubblico alle tematiche dell’efficienza ha portato, negli ultimi anni, allo sviluppo e alla diffusione di prodotti innovativi e multifunzionali: gli intonaci isolanti.
Prodotti similari agli intonaci tradizionali per modalità applicative, ma con proprietà coibenti che possono essere sfruttare per l'isolamento dell'involucro edilizio, sia internamente che esternamente. In questo Dossier Tecnico scopriamo le caratteristiche, i vantaggi e le applicazioni delle differenti tipologie di intonaco isolante disponibili sul mercato, dalle soluzioni più moderne a quelle che sfruttano il potenziale di materiali naturali e già ampiamente apprezzati
Dal classico intonaco all'intonaco isolante
L'intonaco è lo strato superficiale più esterno dell'involucro edilizio. Lo si trova sia internamente all'edificio che esternamente e svolge, in base alla sua collocazione, un ruolo diverso: all'esterno deve assolvere una funzione prevalentemente protettiva, mentre all'interno svolge la funzione di finitura, generalmente, ma non necessariamente, di base alla tinteggiatura e pertanto si tende a considerarne prevalentemente il ruolo estetico-decorativo.
Nel sistema dell'involucro edilizio vengono distinti i vari componenti del manufatto, solitamente tale distinzione si concentra sugli elementi perimetrali suddividendoli in superfici opache e superfici trasparenti, principalmente al fine di individuare le caratteristiche prestazionali (in termini energetici) degli elementi strutturali e di tamponamento. Le superfici trasparenti identificano tutti gli elementi che lasciano penetrare all'interno la luce naturale (serramenti, vetrate, lucernari, etc.), le superfici opache, che nella maggior parte dei casi rappresentano la maggiore percentuale rispetto alle superfici dell'intero involucro edilizio, identificano le parti murarie intese nel loro complesso e pertanto includendo la stratigrafia dei materiali che le compongono. Ecco che, semplificando a titolo di esempio, in una stratigrafia-tipo si troveranno la componente strutturale (calcestruzzo armato, blocchi, acciaio, legno, etc.), le componenti di tamponamento (laterizio, legno, etc.), gli strati coibenti (sistema a cappotto, intercapedini, etc.) e gli strati di finitura (intonaco tinteggiato, intonachino, materiali di rivestimento di facciata, etc.).
Alla luce di questo, come accennato in apertura, si evince quanto sia importante la componente protettiva data dall'intonaco, il quale esternamente dovrà difendere gli elementi sottostanti dalle intemperie, nonché conferire loro una certa stabilità meccanica agendo, inoltre, come ulteriore strato isolante termoacustico per gli ambienti interni.
Tradizionalmente, l'intonaco è una malta ottenuta miscelando acqua, un legante minerale e un inerte: le componenti idraulica e legante (o indurente) inglobano inerti di dimensione granulometrica selezionata compresa generalmente tra i 3 mm e 800 µm. Una prima distinzione tra le tipologie di intonaco si basa sul legante:
- intonaco a base di calce (calce idrata o calce idraulica, in forma di polvere o grassello);
- intonaco calce-cemento, in cui il legante è una miscela di calce idrata e cemento Portland;
- intonaco a base di gesso;
- intonaco a base di argilla.
L'inerte comunemente usato nella miscelazione degli intonaci è la sabbia, la quale può essere calcarea, silicea, naturale (ad esempio fluviale) o derivante da macinazione.

La miscela ottenuta si stende sulle superfici grezze, generalmente in più strati costituiti da granulometrie decrescenti, per uno spessore variabile minimo di 1 cm sino ad arrivare, in casi particolari, a 10 cm. Storicamente la stesura dell'intonaco prevede tre strati (o mani) così distinti:
- rinzaffo: primo strato a contatto con la muratura applicato in maniera non uniforme, la sua granulometria grossolana crea una superficie ruvida che funge da aggrappante per gli strati successivi nonché di rafforzamento data l'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Nei casi di ristrutturazione e restauro viene affogata in esso una rete, plastica o metallica a maglie fitte, che lo rende parte integrante e solidale negli interventi di consolidamento strutturale (intonaco armato);
- arriccio: di granulometria media (massimo 1,5 mm), viene applicato in spessori che variano da 1 a 2 cm ed ha una funzione uniformante sulle superfici parietali, andando a eliminare tutti gli eventuali difetti di planarità e verticalità; inoltre costituisce la vera e propria barriera protettiva degli strati sottostanti nonché la base portante per gli strati successivi di finitura;
- stabilitura: detta anche intonachino, intonaco civile o velo, strato finale di spessore ridotto (inferiore al centimetro) costituito da miscela a granulometria fine, che ha funzione di finitura muraria pronta per accogliere la tinteggiatura o per costituire la finitura stessa se additivato con coloranti.
Strumenti per l'edilizia moderna: l'intonaco premiscelato come precursore dell'intonaco isolante
Le tipologie di applicazione dell'intonaco possono essere differenti a seconda del prodotto, nell'edilizia moderna, infatti, si sono diffusi da tempo prodotti premiscelati pronti alla stesura che facilitano e riducono sensibilmente i tempi e i metodi di posa. Tra questi rientrano i cosiddetti intonaci monostrato, costituiti da due effettive mani di intonaco, date però in sequenza rapida, ossia senza che per il secondo strato sia necessaria l'asciugatura del primo, facendo sì che il corpo d'intonaco risulti come un unico strato piuttosto spesso, e gli intonaci adatti all'applicazione mediante intonacatrici a spruzzo.
L'attenzione sempre crescente per il risparmio energetico e il contenimento delle dispersioni termiche negli edifici determinato dalla maggiore sensibilizzazione di produttori e consumatori e dalle sempre più rigorose leggi in materia, negli ultimi anni ha portato allo sviluppo, ormai maturo e consolidato, dei cosiddetti intonaci isolanti. Si tratta di prodotti premiscelati a secco (che vengono mescolati con acqua in opera mediante apposite macchine impastatrici fino ad ottenere una composizione omogenea) nei quali la composizione tradizionale dell'intonaco viene modificata affinché questo strato possa contribuire notevolmente alle necessità di coibentazione dell'involucro edilizio, sfruttando virtuosamente anche il fatto di costituirne lo strato più esterno, arrivando anche in abbinamento ad adeguate tipologie costruttive, a poter essere il solo elemento coibente di un edificio. I principali vantaggi di questi intonaci termoisolanti sono:
- il ridotto spessore che vanno ad occupare rispetto ad altri sistemi di isolamento, il che li rende particolarmente adatti negli interventi di ristrutturazione e restauro;
- il fatto che, se additivati con specifiche sostanze, possano sopperire a più funzioni (deumidificazione, isolamento acustico, resistenza al fuoco, etc.);
- la maggiore traspirabilità rispetto ai più diffusi sistemi di isolamento;
- la possibilità di essere adatti ad uso interno ed esterno.

Com'è noto, riprendendo quanto qui accennato in introduzione, affinché l'involucro edilizio di un edificio risulti ben realizzato, si devono considerare, in fase di progettazione e di costruzione, gli accorgimenti necessari a limitare la dispersione di energia (ad esempio la naturale dispersione di calore di un locale riscaldato nel periodo invernale verso l'ambiente esterno) attraverso le superfici opache e trasparenti:
- uno strato coibente adeguatamente progettato posto sulle superfici;
- superfici trasparenti a basso valore di trasmittanza termica che limitino al minimo le dispersioni di calore nel periodo invernale e che proteggano dall'irraggiamento nel periodo estivo.
La conducibilità termica λ (W/mK) esprime l'attitudine di un materiale a condurre il calore: la capacità isolante di un materiale è inversamente proporzionale al valore λ. Più quest'ultimo sarà alto, minore sarà il potere isolante del materiale; tuttavia non è soltanto questo che va considerato nella realizzazione di un buon involucro edilizio, infatti le proprietà isolanti di un materiale possono essere inficiate, ad esempio, da una posa scorretta, la quale può dar luogo a ponti termici, ossia quei punti nodali dell'edificio nei quali la dispersione energetica è favorita, ad esempio:
- dal raccordo tra diversi materiali (murature, fondazioni, solai, tamponamenti, copertura, ecc.) i quali presentano differente continuità termica;
- punti di collegamento tra strutture murarie e differenti elementi (infissi e serramenti, cassoni di contenimento di tapparelle ed elementi oscuranti, soglie e davanzali, canne fumarie, ecc.);
- elementi architettonici a sbalzo, cavedi, camini e canne fumarie;
- elementi a diretto contatto con il suolo o con ambienti non climatizzati.
La coibentazione, così come la correzione dei ponti termici, è spesso penalizzata e difficoltosa in alcuni interventi edilizi, quali ad esempio la ristrutturazione/riqualificazione di una singola unità immobiliare all'interno di un complesso di più unità o negli edifici in aderenza ad altri edifici (come nel caso delle costruzioni a schiera), ossia in tutti quei casi in cui vi siano difficoltà oggettive per la posa di un adeguato coibente. L'utilizzo dell'intonaco coibentante costituisce, grazie alle caratteristiche dette sopra, una soluzione efficace sia nei casi sopracitati, data la possibilità di poter agire dall'interno, sia nella correzione dei ponti termici in quanto, mediante esso, è possibile realizzare uno strato isolante omogeneo e continuo sulla totalità delle superfici opache di un edificio anche nei punti più delicati (gli aggetti architettonici, le "spallette" dei serramenti, etc.).
Intonaco isolante: composti, prodotti e differenti applicazioni
Le varianti di composizione tra l'intonaco tradizionale e l'intonaco termoisolante avvengono mediante la sostituzione o l'aggiunta, nella miscela, di inerti di materiali dotati di proprietà termoisolanti, spesso anche fonoisolanti/fonoassorbenti, i quali possono essere di origine sintetica o naturale; inoltre, nella miscela possono essere inseriti ulteriori materiali e additivi atti a...